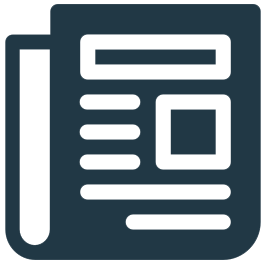Il videogioco è un linguaggio. Ma chi lo conosce?
La mancata "literacy" è anche un ostacolo allo sviluppo di progetti educativi
Francesco Toniolo
|29 giorni fa

Per comprendere il videogioco bisogna conoscerne il linguaggio- © Libertà
Il videogioco è come un linguaggio. Se non ne conosciamo la “grammatica”, se non sviluppiamo una literacy (un’alfabetizzazione) videoludica, non avremo alcun modo di capirlo, ci sembrerà sempre qualcosa di alieno e indecifrabile. Come una tavoletta piena di scritte in sumerico. Eppure il linguaggio videoludico è diffusissimo, soprattutto tra le nuove generazioni. E qui nasce il problema: molti genitori e insegnanti non parlano questa lingua. A volte non vogliono impararla, la rifiutano a priori. Altri vorrebbero, ma non sanno da dove cominciare. E così si crea una frattura culturale che li porta a vedere i ragazzi come dei misteriosi alieni che parlano di cose “senza senso”.
Oltre ad essere un problema comunicativo, questa mancata literacy è anche un ostacolo concreto allo sviluppo di progetti educativi. Come si può pensare di usare Minecraft Education in classe, se non si sa nemmeno cosa sia Minecraft? Si finisce per rigettare le nuove proposte a priori o per avere un’idea astratta e confusa di quel mondo, incasellata sotto qualche etichetta teorica come “game based learning”, “gamification scolastica” o dintorni. Ma è tutto inutile se poi non si è in grado di passare dalla teoria alla pratica e l’attività più ludica che si riesce a concepire è un quiz a risposte multiple.
Oltre ad essere un problema comunicativo, questa mancata literacy è anche un ostacolo concreto allo sviluppo di progetti educativi. Come si può pensare di usare Minecraft Education in classe, se non si sa nemmeno cosa sia Minecraft? Si finisce per rigettare le nuove proposte a priori o per avere un’idea astratta e confusa di quel mondo, incasellata sotto qualche etichetta teorica come “game based learning”, “gamification scolastica” o dintorni. Ma è tutto inutile se poi non si è in grado di passare dalla teoria alla pratica e l’attività più ludica che si riesce a concepire è un quiz a risposte multiple.

Non sto dicendo che sia facile. Io per primo faccio tanti incontri di formazione per docenti e capisco le loro problematiche. A volte c’è la buona volontà ma manca ogni risorsa: temporale, monetaria, tecnologica o altro. Ma a volte c’è il rifiuto di tutto questo. Che forse nasce dalla paura di quel qualcosa che appare così strano e alieno.
Anche chi lavora in ambito psicologico e terapeutico si scontra con questa realtà. Penso per esempio alla squadra della Video Game Therapy guidata dallo psicologo Francesco Bocci, che propone un approccio terapeutico integrato che utilizza i videogiochi per promuovere il benessere psicologico, emotivo e cognitivo. Giovedì scorso ho partecipato con loro al convegno “Playing Futures: videogames per il benessere” all’Università degli Studi Link, dove si è parlato anche di questo: spesso è utile far provare i videogiochi ad altri adulti, siano essi genitori, insegnanti, terapeuti o altro. Questa attività, soprattutto quando inserita all’interno di un percorso strutturato, genera dei vantaggi enormi, nella comunicazione con le generazioni più giovani. Ti permette non solo di capirli, ma anche di comprendere come usare il medium, cosa sia meglio proporre loro. E, perché no, ci si diverte anche un po’, cosa che non fa male, per un adulto spesso sommerso da incombenze burocratiche e preoccupazioni lavorative.
Anche chi lavora in ambito psicologico e terapeutico si scontra con questa realtà. Penso per esempio alla squadra della Video Game Therapy guidata dallo psicologo Francesco Bocci, che propone un approccio terapeutico integrato che utilizza i videogiochi per promuovere il benessere psicologico, emotivo e cognitivo. Giovedì scorso ho partecipato con loro al convegno “Playing Futures: videogames per il benessere” all’Università degli Studi Link, dove si è parlato anche di questo: spesso è utile far provare i videogiochi ad altri adulti, siano essi genitori, insegnanti, terapeuti o altro. Questa attività, soprattutto quando inserita all’interno di un percorso strutturato, genera dei vantaggi enormi, nella comunicazione con le generazioni più giovani. Ti permette non solo di capirli, ma anche di comprendere come usare il medium, cosa sia meglio proporre loro. E, perché no, ci si diverte anche un po’, cosa che non fa male, per un adulto spesso sommerso da incombenze burocratiche e preoccupazioni lavorative.

Non si tratta di diventare esperti o gamer incalliti, ma di aver voglia di fare qualche partita o, perlomeno, di sedersi di fianco al proprio figlio (o nipote, o qualsiasi altra cosa) e guardare mentre gioca, domandando che cosa sta facendo e perché quell’attività è così interessante. Il gaming intergenerazionale è uno strumento potentissimo, un ponte tra persone che altrimenti potrebbero far fatica a comunicare.
Senza questa alfabetizzazione, si rischia di inseguire mode educative senza comprenderle davvero. Si parla di laboratori digitali, di realtà virtuale, di apprendimento immersivo e sembra tutto complicatissimo, ma a volte basta poco: basta chiedere “mi spieghi come si gioca? Mi fai provare?”.
Senza questa alfabetizzazione, si rischia di inseguire mode educative senza comprenderle davvero. Si parla di laboratori digitali, di realtà virtuale, di apprendimento immersivo e sembra tutto complicatissimo, ma a volte basta poco: basta chiedere “mi spieghi come si gioca? Mi fai provare?”.
IL GAME BASED LEARNING E' INUTILE, SE RESTA SOLO UN'ETICHETTA
Negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso di game based learning, ovvero l’uso dei giochi come strumento di apprendimento. Per chi lavora in contesti scolastici o comunque educativi e formativi, sicuramente ne avrà sentito parlare, elencato in mezzo a tante altre metodologie didattiche innovative. Generalmente viene affiancato a un altro termine, gamification, che è circolato un po’ di più anche al di fuori del mondo scolastico. La gamification definisce l’uso di meccaniche ludiche in contesti non ludici, per cui non è perfettamente sovrapponibile al game based learning. Facciamo un esempio concreto, così è più chiaro. Se un docente struttura delle domande di ripasso con un quiz interattivo a punti, magari con dei punteggi bonus per determinate azioni, sta gamificando un’attività non ludica (il ripasso) inserendo al suo interno degli elementi di gioco. Nel game based learning, invece, il docente fa giocare la classe a un gioco (anche di quelli commerciali, non deve essere stato creato con apposite finalità educative) e usa quell’attività per aprire un dibattito, generare riflessioni, introdurre un argomento del programma o altro ancora.
Può trattarsi di un videogioco, di un gioco da tavolo, di carte o di ruolo: ciò che conta non è la forma, ma la funzione. Il gioco diventa un modello della realtà, uno spazio controllato in cui i partecipanti possono sperimentare situazioni complesse, prendere decisioni, confrontarsi con conseguenze e riflettere sulle dinamiche vissute. Perché il game based learning funzioni davvero, la scelta dei temi e degli obiettivi formativi è cruciale. Un esempio: se voglio affrontare con un gruppo il tema della gestione del rischio, potrei proporre un gioco in cui la casualità e le probabilità hanno un ruolo determinante. Se invece desidero sviluppare la collaborazione, la soluzione migliore sarà un gioco cooperativo, dove la vittoria dipende dallo sforzo collettivo più che dalle abilità individuali.
Negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso di game based learning, ovvero l’uso dei giochi come strumento di apprendimento. Per chi lavora in contesti scolastici o comunque educativi e formativi, sicuramente ne avrà sentito parlare, elencato in mezzo a tante altre metodologie didattiche innovative. Generalmente viene affiancato a un altro termine, gamification, che è circolato un po’ di più anche al di fuori del mondo scolastico. La gamification definisce l’uso di meccaniche ludiche in contesti non ludici, per cui non è perfettamente sovrapponibile al game based learning. Facciamo un esempio concreto, così è più chiaro. Se un docente struttura delle domande di ripasso con un quiz interattivo a punti, magari con dei punteggi bonus per determinate azioni, sta gamificando un’attività non ludica (il ripasso) inserendo al suo interno degli elementi di gioco. Nel game based learning, invece, il docente fa giocare la classe a un gioco (anche di quelli commerciali, non deve essere stato creato con apposite finalità educative) e usa quell’attività per aprire un dibattito, generare riflessioni, introdurre un argomento del programma o altro ancora.
Può trattarsi di un videogioco, di un gioco da tavolo, di carte o di ruolo: ciò che conta non è la forma, ma la funzione. Il gioco diventa un modello della realtà, uno spazio controllato in cui i partecipanti possono sperimentare situazioni complesse, prendere decisioni, confrontarsi con conseguenze e riflettere sulle dinamiche vissute. Perché il game based learning funzioni davvero, la scelta dei temi e degli obiettivi formativi è cruciale. Un esempio: se voglio affrontare con un gruppo il tema della gestione del rischio, potrei proporre un gioco in cui la casualità e le probabilità hanno un ruolo determinante. Se invece desidero sviluppare la collaborazione, la soluzione migliore sarà un gioco cooperativo, dove la vittoria dipende dallo sforzo collettivo più che dalle abilità individuali.

Finché si resta sul piano della teoria, forse sembra più facile della gamification, visto che non bisogna creare niente da zero visto che si utilizza un gioco preesistente, ma in realtà ci sono tanti problemi. Io stesso ho potuto osservarli da vicino nel corso degli anni, avendo diversi incontri di formazione per docenti intorno a questi temi. Ho visto che tanti docenti sono interessati e volenterosi, ma partono con un’aspettativa che finisce per deluderli: quella di trovare dei giochi adatti alla loro materia, allo specifico argomento che vogliono trattare e alle esigenze della specifica classe che hanno davanti. Non dico che sia impossibile, ma è rarissimo. E anche quando un gioco del genere esiste, i problemi possono emergere in altro modo. Potrebbe essere un gioco troppo lungo da portare a termine, potrebbe essere un videogioco disponibile solo su console o potrebbe anche… essere noiosissimo! Magari proprio perché è stato creato con un intento educativo esplicito che si è “mangiato” il divertimento. Per cui potrebbe finire per esser anche peggio della classica e (spesso ingiustamente) bistrattata lezione frontale.
Per cui – a meno di non essere molto fortunati nel trovare il gioco giusto – le soluzioni sono tre. O si ritorna sulla gamification, tentando di rendere interattiva qualche tradizionale attività scolastica. O si crea un gioco da zero, ma questo richiede ovviamente tempo, passione e capacità. O si accetta di utilizzare un gioco stimolante, con qualcosa da dire, capace di aprire un dibattito, anche se questo non è direttamente legato al programma della propria materia.
In realtà c’è anche una quarta soluzione: lasciar perdere. Inserire il game based learning nel cassetto dove stanno tutte le altre metodologie didattiche innovative ascoltate in qualche corso di formazione e poi mai applicate. E lo capisco benissimo. Anche i docenti volenterosi finiscono spesso per arrendersi, davanti alla proposta dell’ennesima piattaforma da provare per fare qualche attività con le classi, come se non avessero già tutte le piattaforme ministeriali a cui dover stare dietro. E in quei casi è inutile portare studi sui benefici potenziali. Quello che, al più, posso fare, è condividere esperienze positive a cui ho assistito direttamente, dove portare il gioco a scuola è stato un grande aiuto, altrimenti rimane solo astrazione, ma capisco per primo le difficoltà di una reale applicazione e sono il primo a non volerle nascondere.
Per cui – a meno di non essere molto fortunati nel trovare il gioco giusto – le soluzioni sono tre. O si ritorna sulla gamification, tentando di rendere interattiva qualche tradizionale attività scolastica. O si crea un gioco da zero, ma questo richiede ovviamente tempo, passione e capacità. O si accetta di utilizzare un gioco stimolante, con qualcosa da dire, capace di aprire un dibattito, anche se questo non è direttamente legato al programma della propria materia.
In realtà c’è anche una quarta soluzione: lasciar perdere. Inserire il game based learning nel cassetto dove stanno tutte le altre metodologie didattiche innovative ascoltate in qualche corso di formazione e poi mai applicate. E lo capisco benissimo. Anche i docenti volenterosi finiscono spesso per arrendersi, davanti alla proposta dell’ennesima piattaforma da provare per fare qualche attività con le classi, come se non avessero già tutte le piattaforme ministeriali a cui dover stare dietro. E in quei casi è inutile portare studi sui benefici potenziali. Quello che, al più, posso fare, è condividere esperienze positive a cui ho assistito direttamente, dove portare il gioco a scuola è stato un grande aiuto, altrimenti rimane solo astrazione, ma capisco per primo le difficoltà di una reale applicazione e sono il primo a non volerle nascondere.