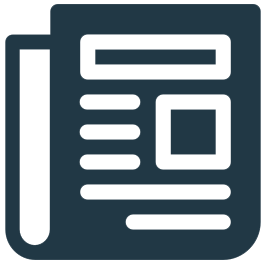"Zitta e buona": Stefanini e le altre vittime del Terrorismo rosso
Nel podcast di Elisabetta Fusconi prodotto da Radio 24
Claudia Labati
|3 mesi fa

La copertina del podcast - © Libertà/Claudia Labati
La storia del nostro Paese si ricostruisce anche grazie alle voci. Grazie a questo bellissimo e completo podcast “Zitta e Buona” di Elisabetta Fusconi, prodotto da Radio 24, riusciamo ad immergerci completamente negli anni tremendi e sanguinari del terrorismo in Italia: voci che escono a un “mangianastri” - come lo chiamava mia nonna - un po’ metalliche, sporcate dall’imperfezione, ma che ci ricordano quanto la memoria sia un atto di resistenza civile. L’autrice si imbatte in un articolo di Giovanni Bianconi che ricordava la storia di due donne vittime della furia brigatista: Germana Stefanini, 57 anni, dipendente penitenziaria a Rebibbia, addetta allo smistamento dei pacchi per le detenute, e Giuseppina Galfo, medico penitenziario nello stesso carcere: vittime innocenti di attacchi efferati da parte del Nucleo per il Potere Proletario Armato, irriducibili militanti del terrorismo rosso. Era il 1983, si viveva tra gli strascichi di quelli che erano stati gli anni di piombo e un clima di apparente leggerezza, ben lontano dagli anni bui appena trascorsi. Eppure, il seme della violenza alimentata dall’odio politico non è ancora stato estirpato. La giornalista inizia un lungo lavoro di ricerca: ben nove faldoni polverosi, pieni zeppi di documenti, registrazioni magnetiche e un’audiocassetta. Ed ecco il punto di svolta del podcast: la voce di Germana Stefanini, terrorizzata ma mai supplichevole, ci investe con una forza quasi insopportabile: È la voce di un’interrogata durante un “processo proletario” mentre risponde alle domande incalzanti del comitato di esecuzione dei tre giovani brigatisti armati che la incalzano con domande rabbiose e toni durissimi. Ancora una volta l’ascolto ci riporta ad una dimensione reale, direi storica, quasi più delle immagini.

La vera forza dei podcast, lo sostengo da sempre. Ore di interrogatorio incalzante, i toni duri, e quell’ordine ripetuto: «Zitta e buona». La condanna è già scritta, annientamento. Dopo ore di incubo, Germana verrà uccisa e ritrovata nel bagagliaio di una Fiat 131, proprio come accadde anni prima con Aldo Moro. Un processo proletario in piena regola, che aveva subito due mesi prima anche la dottoressa Giuseppina Galfo: sequestrata, interrogata e registrata dal vivo, ferita alla testa. Contro ogni previsione sopravvisse, diventando la prima vittima designata di una campagna contro le carceri che i brigatisti volevano portare avanti con spietata determinazione. La serie podcast prosegue con la ricostruzione della cattura dei tre responsabili – Francesco Donati, Carlo Garavaglia e Barbara Fabrizi – che ancora oggi scontano la loro pena, senza mai essersi pentiti o dissociati dalle loro azioni sanguinarie. Una parte difficile da ascoltare, perché l’efferatezza dei gesti resta inspiegabile, soprattutto quando ha per bersaglio due donne che facevano semplicemente il loro lavoro. Un podcast assolutamente imperdibile, ben calibrato tra documenti audio e interviste ricche di senso: mai una parola giudicante, fuori posto, solo un importante lavoro di ricostruzione intelligente ed emozionante. Direi, necessario.
LA MEMORIA DI GERMANA E' STATA PIU' VOLTE ONORATA
Negli anni Settanta e Ottanta, le carceri italiane erano luoghi di tensione continua. Celle sovraffollate, condizioni igieniche precarie e un sistema penitenziario percepito come disumano alimentavano un forte malcontento sociale. In quegli anni maturò quella che venne definita la “rivoluzione carceraria”: un intreccio di proteste, rivolte interne e campagne di denuncia che coinvolsero tanto la sinistra istituzionale quanto i movimenti extraparlamentari. La prigione diventava simbolo di oppressione e terreno fertile per un discorso politico che metteva insieme richieste legittime di riforma e derive violente. Mentre giornali, associazioni e intellettuali sollevavano l’attenzione sulle condizioni disumane dei detenuti, i gruppi eversivi scelsero di radicalizzare questa battaglia. Performazioni come il Nucleo per il Potere proletario armato, legato all’orbita brigatista, la lotta contro le carceri non poteva fermarsi a manifestazioni o articoli di denuncia: doveva trasformarsi in “giustizia rivoluzionaria”.
Da qui la scelta di colpire chi nelle carceri lavorava. Nel 1982 viene rapita e ferita il medico penitenziario Giuseppina Galfo; pochi mesi dopo, nel gennaio 1983, la dipendente penitenziaria Germana Stefanini viene sequestrata e uccisa. Sono le prime, e uniche, donne mai prese di mira dal terrorismo rosso: simboli di un’istituzione ritenuta da abbattere, più che persone. Negli anni successivi, la memoria di Germana è stata più volte onorata. Nel 2007 le è stata conferita la Medaglia d’oro al Merito civile, nel 2012 Roma le ha dedicato una strada e dal 2017 la Casa circondariale femminile di Rebibbia porta il suo nome. Nel novembre 2023 una cerimonia ufficiale l’ha ricordata alla presenza del Guardasigilli e dei vertici dell’amministrazione penitenziaria. La famiglia, tuttavia, non si è mai costituita parte civile nei processi contro i suoi assassini, preferendo lottare affinché la memoria di Germana Stefanini venisse ricordata dalle istituzioni e soprattutto dalle donne.
Negli anni Settanta e Ottanta, le carceri italiane erano luoghi di tensione continua. Celle sovraffollate, condizioni igieniche precarie e un sistema penitenziario percepito come disumano alimentavano un forte malcontento sociale. In quegli anni maturò quella che venne definita la “rivoluzione carceraria”: un intreccio di proteste, rivolte interne e campagne di denuncia che coinvolsero tanto la sinistra istituzionale quanto i movimenti extraparlamentari. La prigione diventava simbolo di oppressione e terreno fertile per un discorso politico che metteva insieme richieste legittime di riforma e derive violente. Mentre giornali, associazioni e intellettuali sollevavano l’attenzione sulle condizioni disumane dei detenuti, i gruppi eversivi scelsero di radicalizzare questa battaglia. Performazioni come il Nucleo per il Potere proletario armato, legato all’orbita brigatista, la lotta contro le carceri non poteva fermarsi a manifestazioni o articoli di denuncia: doveva trasformarsi in “giustizia rivoluzionaria”.
Da qui la scelta di colpire chi nelle carceri lavorava. Nel 1982 viene rapita e ferita il medico penitenziario Giuseppina Galfo; pochi mesi dopo, nel gennaio 1983, la dipendente penitenziaria Germana Stefanini viene sequestrata e uccisa. Sono le prime, e uniche, donne mai prese di mira dal terrorismo rosso: simboli di un’istituzione ritenuta da abbattere, più che persone. Negli anni successivi, la memoria di Germana è stata più volte onorata. Nel 2007 le è stata conferita la Medaglia d’oro al Merito civile, nel 2012 Roma le ha dedicato una strada e dal 2017 la Casa circondariale femminile di Rebibbia porta il suo nome. Nel novembre 2023 una cerimonia ufficiale l’ha ricordata alla presenza del Guardasigilli e dei vertici dell’amministrazione penitenziaria. La famiglia, tuttavia, non si è mai costituita parte civile nei processi contro i suoi assassini, preferendo lottare affinché la memoria di Germana Stefanini venisse ricordata dalle istituzioni e soprattutto dalle donne.