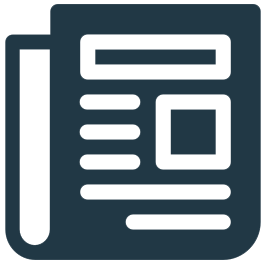Roberta Biagiarelli: «Con la voce racconto ciò che non deve più accadere»
Dal teatro al podcast "Il genocidio dimenticato" prodotto da Chora Media
Claudia Labati
|3 mesi fa

La copertina del podcast "Srebrenica. Il genocidio dimenticato" di Roberta Biagiarelli e Paolo Rumiz- © Libertà/Claudia Labati
Incontro Roberta un giorno di fine agosto, nella campagna ferrarese, durante un festival di podcast a cui entrambe partecipiamo. Capisco immediatamente che è una “felice coincidenza”, come le chiama lei.
Conoscevo già il suo podcast – un successo di ascolti straordinario quest’estate – ma non l’avevo ancora ascoltato. Così, macino chilometri sull’Autosole e schiaccio play: mi immergo con emozione in quella che non è una storia, ma la nostra storia.
Nel trentennale del genocidio di Srebrenica, Roberta Biagiarelli, attrice, autrice multidisciplinare e voce civile, ha scelto di continuare il suo impegno per raccontare quella ferita europea con un nuovo linguaggio: il podcast.
Dopo ventotto anni di repliche del suo celebre monologo A come Srebrenica, Biagiarelli ha pubblicato per Chora Media, in collaborazione con Paolo Rumiz, Srebrenica. Il genocidio dimenticato, con la consulenza storica di Simone Malavolta e la collaborazione di Azra Nuhefendić.
Srebrenica è per Roberta Biagiarelli un punto di partenza: da quella ferita è nato un viaggio che attraversa memoria, incontri e nuovi progetti, alla ricerca di un modo per leggere il presente alla luce della Storia.
L’abbiamo raggiunta per una conversazione intensa sulla memoria e sulla responsabilità delraccontare.
Conoscevo già il suo podcast – un successo di ascolti straordinario quest’estate – ma non l’avevo ancora ascoltato. Così, macino chilometri sull’Autosole e schiaccio play: mi immergo con emozione in quella che non è una storia, ma la nostra storia.
Nel trentennale del genocidio di Srebrenica, Roberta Biagiarelli, attrice, autrice multidisciplinare e voce civile, ha scelto di continuare il suo impegno per raccontare quella ferita europea con un nuovo linguaggio: il podcast.
Dopo ventotto anni di repliche del suo celebre monologo A come Srebrenica, Biagiarelli ha pubblicato per Chora Media, in collaborazione con Paolo Rumiz, Srebrenica. Il genocidio dimenticato, con la consulenza storica di Simone Malavolta e la collaborazione di Azra Nuhefendić.
Srebrenica è per Roberta Biagiarelli un punto di partenza: da quella ferita è nato un viaggio che attraversa memoria, incontri e nuovi progetti, alla ricerca di un modo per leggere il presente alla luce della Storia.
L’abbiamo raggiunta per una conversazione intensa sulla memoria e sulla responsabilità delraccontare.
Il suo monologo A come Srebrenica ha segnato una generazione. Cosa ha significato per lei trasformare questa esperienza in un podcast?
«Il podcast è stato per me una nuova scena. Dopo ventotto anni di repliche di A come Srebrenica ho sentito il bisogno di trovare un altro modo per condividere quella storia, di raggiungere persone più giovani che magari non vanno a teatro. Ma la radice resta la stessa: il teatro del reale, che non è mai solo rappresentazione, ma un modo per capire il presente. La voce, nel podcast, diventa corpo e spazio: costruisce memoria attraverso il respiro, il ritmo, il silenzio. È stato come riattraversare il mio lavoro, con un linguaggio diverso ma con la stessa urgenza».
«Il podcast è stato per me una nuova scena. Dopo ventotto anni di repliche di A come Srebrenica ho sentito il bisogno di trovare un altro modo per condividere quella storia, di raggiungere persone più giovani che magari non vanno a teatro. Ma la radice resta la stessa: il teatro del reale, che non è mai solo rappresentazione, ma un modo per capire il presente. La voce, nel podcast, diventa corpo e spazio: costruisce memoria attraverso il respiro, il ritmo, il silenzio. È stato come riattraversare il mio lavoro, con un linguaggio diverso ma con la stessa urgenza».
Che ruolo hanno avuto la collaborazione con Paolo Rumiz e Chora Media nella costruzione di questa narrazione sonora?
«Paolo Rumiz è stato fondamentale: è mio amico da trent’anni, il mio “maestro dei Balcani”. Mi ha regalato quelle che io chiamo le sue pennellate balcaniche, frammenti di viaggio e di umanità che danno al podcast una profondità particolare. Accanto a lui c’è stato Simone Malavolta, lo storico che ha curato la consulenza scientifica. È importante citarlo: mi ha aiutata a verificare ogni dettaglio, perché la precisione storica è parte della responsabilità del racconto. E poi Asja Aslan, giornalista di Sarajevo e amica del cuore, che ha portato nel testo lo sguardo interno, quello di chi ha vissuto la guerra da dentro. Senza di loro non avrei potuto costruire questa coralità di voci. Il podcast, per me, era un linguaggio nuovo: fondamentale è stato anche l’apporto della divisione giornalistica di Chora Media, senza la quale non avremmo ottenuto questo risultato».
«Paolo Rumiz è stato fondamentale: è mio amico da trent’anni, il mio “maestro dei Balcani”. Mi ha regalato quelle che io chiamo le sue pennellate balcaniche, frammenti di viaggio e di umanità che danno al podcast una profondità particolare. Accanto a lui c’è stato Simone Malavolta, lo storico che ha curato la consulenza scientifica. È importante citarlo: mi ha aiutata a verificare ogni dettaglio, perché la precisione storica è parte della responsabilità del racconto. E poi Asja Aslan, giornalista di Sarajevo e amica del cuore, che ha portato nel testo lo sguardo interno, quello di chi ha vissuto la guerra da dentro. Senza di loro non avrei potuto costruire questa coralità di voci. Il podcast, per me, era un linguaggio nuovo: fondamentale è stato anche l’apporto della divisione giornalistica di Chora Media, senza la quale non avremmo ottenuto questo risultato».
Come ha usato la tua voce rispetto alla scena teatrale, in questa nuova forma narrativa?
«A teatro il corpo domina, mentre nel podcast la voce deve diventare tutto: corpo, luce, spazio. Sembra una banalità, ma ti faccio un esempio: ho registrato le parti teatrali in piedi, con una postura da scena, e le parti narrative seduta, più raccolta, per differenziare i piani emotivi. Nel suono puoi essere più intima, ma anche più universale. Il pubblico entra dentro, senza immagini: è un ascolto che ti obbliga a immaginare. La memoria passa per l’orecchio, non per l’occhio».
«A teatro il corpo domina, mentre nel podcast la voce deve diventare tutto: corpo, luce, spazio. Sembra una banalità, ma ti faccio un esempio: ho registrato le parti teatrali in piedi, con una postura da scena, e le parti narrative seduta, più raccolta, per differenziare i piani emotivi. Nel suono puoi essere più intima, ma anche più universale. Il pubblico entra dentro, senza immagini: è un ascolto che ti obbliga a immaginare. La memoria passa per l’orecchio, non per l’occhio».
Lei parla spesso di “teatro del reale”: il podcast può essere considerato un’altra forma di coscienza, dopo trent’anni di lavoro sulla memoria di Srebrenica?
«Per me il teatro e il podcast sono entrambi un atto politico e umano. Quando faccio teatro porto lo spettatore a ragionare con me: non è un teatro subìto. È un modo per contrastare l’oblio, per restituire dignità alle storie. La storia dei Balcani è molto complessa - lo si capisce già nella prima puntata del podcast - ma è necessario attraversarla per spiegare ottocento anni di stratificazioni. Oggi continuo a lavorare nei Balcani: porto studenti e spettatori nei luoghi del genocidio, nelle case dei sopravvissuti. Molti di loro mi scrivono dopo anni: “Ho visto il tuo monologo e ho scelto di occuparmi di diritti umani”. Ecco, per me questo è il senso: piantare semi di consapevolezza. La memoria non è mai nostalgia, è azione».
«Per me il teatro e il podcast sono entrambi un atto politico e umano. Quando faccio teatro porto lo spettatore a ragionare con me: non è un teatro subìto. È un modo per contrastare l’oblio, per restituire dignità alle storie. La storia dei Balcani è molto complessa - lo si capisce già nella prima puntata del podcast - ma è necessario attraversarla per spiegare ottocento anni di stratificazioni. Oggi continuo a lavorare nei Balcani: porto studenti e spettatori nei luoghi del genocidio, nelle case dei sopravvissuti. Molti di loro mi scrivono dopo anni: “Ho visto il tuo monologo e ho scelto di occuparmi di diritti umani”. Ecco, per me questo è il senso: piantare semi di consapevolezza. La memoria non è mai nostalgia, è azione».
Come si può parlare ai più giovani di genocidio, senza retorica ma con responsabilità?
«Con la verità e con il linguaggio giusto. Il podcast mi ha permesso di raggiungere generazioni che non hanno vissuto quella guerra, ma che ne vedono altre. Oggi la memoria di Srebrenica dialoga con Gaza, con le guerre che continuano sulla pelle dei civili. Parlare di genocidio non è un esercizio di storia, è un atto educativo: serve a capire quanto siamo tutti coinvolti. Mi hanno scritto professori ed educatori ringraziandomi, perché il podcast servirà loro per spiegare ai ragazzi di oggi cosa è successo — attenzione, appena trent’anni fa. Questo per me è un risultato bellissimo: l’indifferenza ci uccide più della violenza».
«Con la verità e con il linguaggio giusto. Il podcast mi ha permesso di raggiungere generazioni che non hanno vissuto quella guerra, ma che ne vedono altre. Oggi la memoria di Srebrenica dialoga con Gaza, con le guerre che continuano sulla pelle dei civili. Parlare di genocidio non è un esercizio di storia, è un atto educativo: serve a capire quanto siamo tutti coinvolti. Mi hanno scritto professori ed educatori ringraziandomi, perché il podcast servirà loro per spiegare ai ragazzi di oggi cosa è successo — attenzione, appena trent’anni fa. Questo per me è un risultato bellissimo: l’indifferenza ci uccide più della violenza».
C’è una puntata speciale alla fine, chiamata “Extra”, registrata in maniera diversa. Il suo viaggio narrativo si conclude nei luoghi della memoria, durante la commemorazione dei trent’anni. Quanto è stata importante quella puntata?
«È la mia preferita! L’ho registrata on the road, tra le voci della commemorazione dell’11luglio. Ogni anno ci torno, ma questa volta ho voluto portare con me il microfono. C’erano centomila persone: la diaspora bosniaca da tutto il mondo che si riunisce lì ogni anno. In America ce ne sono tantissimi, ma anche in Italia: Piacenza, per esempio, ha una comunità fortissima. Ho incontrato un ex casco blu, una nonna novantenne venuta da Washington, tantissime persone che non dimenticano e tornano ogni anno. Senza rivelare nulla, dico solo che il caffè offerto da una famiglia di Los Angeles, che possiede ancora la casa di fronte al memoriale, è stato di una forza così semplice e potente da raccontare. Lì la vita entra nella morte, come in un rito».
«È la mia preferita! L’ho registrata on the road, tra le voci della commemorazione dell’11luglio. Ogni anno ci torno, ma questa volta ho voluto portare con me il microfono. C’erano centomila persone: la diaspora bosniaca da tutto il mondo che si riunisce lì ogni anno. In America ce ne sono tantissimi, ma anche in Italia: Piacenza, per esempio, ha una comunità fortissima. Ho incontrato un ex casco blu, una nonna novantenne venuta da Washington, tantissime persone che non dimenticano e tornano ogni anno. Senza rivelare nulla, dico solo che il caffè offerto da una famiglia di Los Angeles, che possiede ancora la casa di fronte al memoriale, è stato di una forza così semplice e potente da raccontare. Lì la vita entra nella morte, come in un rito».
Cosa spera che rimanga, in chi ascolta, dopo l’ultima parola?
«La consapevolezza che la memoria non è un esercizio del passato, ma del presente. Se qualcuno, dopo aver ascoltato Srebrenica. Il genocidio dimenticato capisce qualcosa in più dell’Europa – e del fatto che è necessario educare alla pace per poterla praticare – allora il mio lavoro avrà avuto un senso».
«La consapevolezza che la memoria non è un esercizio del passato, ma del presente. Se qualcuno, dopo aver ascoltato Srebrenica. Il genocidio dimenticato capisce qualcosa in più dell’Europa – e del fatto che è necessario educare alla pace per poterla praticare – allora il mio lavoro avrà avuto un senso».
Roberta Biagiarelli non è solo un’attrice e una podcaster straordinaria: il suo lavoro è un esempio di come si possa fare cultura in Italia arricchendosi ed evolvendosi, e di come anche chi era lontano dalla questione balcanica possa oggi sentirsi parte di una memoria condivisa.

UNA VITA DEDICATA ALLA MEMORIA EUROPEA
La sua mappa astrale, dice, porta a memorie di guerra. E in effetti la vita di Roberta Biagiarelli, nata a Fano nel 1967, si è intrecciata indissolubilmente con una delle pagine più oscure della storia europea recente: Srebrenica. Formata alla scuola del Laboratorio Teatro Settimo di Torino, dove lavora dal 1988 al 2001, Biagiarelli scopre la sua vocazione nel 1998 quando, ispirata dal libro "La guerra in casa" di Luca Rastello, crea insieme a Giovanna Giovannozzi e Simona Gonella il monologo "A come Srebrenica". Da quel momento, la testimonianza storico-teatrale sul genocidio dell'11 luglio 1995 diventa il filo conduttore della sua esistenza:28 anni di repliche ininterrotte, oltre 700 spettacoli in Italia e nel mondo, da Sarajevo a Gerusalemme, fino al Parlamento Europeo di Bruxelles nel 2019.Ma Roberta non è solo un'attrice che racconta. È un'artista multidisciplinare che agisce. Nel 2002 fonda l'associazione "Babelia – progetti culturali" e da lì in poi non si ferma più: realizza il documentario "Souvenir Srebrenica" (finalista ai David di Donatello 2007), diventa esperta dell'area balcanica per il Ministero degli Affari Esteri, coordina progetti di rivitalizzazione socioculturale in Bosnia Erzegovina. Nel 2010 dà vita a "La transumanza della Pace", progetto di solidarietà ancora attivo che porta mucche, trattori e speranza nelle aree devastate dell'Altopiano di Sućeska. Documenta la rotta balcanica dei migranti con il fotoreporter Luigi Ottani, pubblicando "Dal libro dell'esodo" (Piemme, 2016) e "Shooting Sarajevo" (BEE, 2020).Dal 2018 cura il ciclo "Balcani d'Europa – lo specchio di noi", è attivista della Rete "Rivolti ai Balcani" e accompagna viaggi della memoria per Istoreco di Reggio Emilia. Quest'anno, per il30° anniversario del genocidio, ha realizzato con Paolo Rumiz il podcast "Srebrenica - il genocidio dimenticato" per Chora Media, che ha raggiunto la prima posizione su Spotify Italia. «Srebrenica deriva da "srebro", argento - spiega - un ottimo conduttore che amalgama e tiene insieme. È questo il senso più profondo del mio lavoro: mettere in relazione persone lontane che pulsano sulla stessa frequenza d'onda».
La sua mappa astrale, dice, porta a memorie di guerra. E in effetti la vita di Roberta Biagiarelli, nata a Fano nel 1967, si è intrecciata indissolubilmente con una delle pagine più oscure della storia europea recente: Srebrenica. Formata alla scuola del Laboratorio Teatro Settimo di Torino, dove lavora dal 1988 al 2001, Biagiarelli scopre la sua vocazione nel 1998 quando, ispirata dal libro "La guerra in casa" di Luca Rastello, crea insieme a Giovanna Giovannozzi e Simona Gonella il monologo "A come Srebrenica". Da quel momento, la testimonianza storico-teatrale sul genocidio dell'11 luglio 1995 diventa il filo conduttore della sua esistenza:28 anni di repliche ininterrotte, oltre 700 spettacoli in Italia e nel mondo, da Sarajevo a Gerusalemme, fino al Parlamento Europeo di Bruxelles nel 2019.Ma Roberta non è solo un'attrice che racconta. È un'artista multidisciplinare che agisce. Nel 2002 fonda l'associazione "Babelia – progetti culturali" e da lì in poi non si ferma più: realizza il documentario "Souvenir Srebrenica" (finalista ai David di Donatello 2007), diventa esperta dell'area balcanica per il Ministero degli Affari Esteri, coordina progetti di rivitalizzazione socioculturale in Bosnia Erzegovina. Nel 2010 dà vita a "La transumanza della Pace", progetto di solidarietà ancora attivo che porta mucche, trattori e speranza nelle aree devastate dell'Altopiano di Sućeska. Documenta la rotta balcanica dei migranti con il fotoreporter Luigi Ottani, pubblicando "Dal libro dell'esodo" (Piemme, 2016) e "Shooting Sarajevo" (BEE, 2020).Dal 2018 cura il ciclo "Balcani d'Europa – lo specchio di noi", è attivista della Rete "Rivolti ai Balcani" e accompagna viaggi della memoria per Istoreco di Reggio Emilia. Quest'anno, per il30° anniversario del genocidio, ha realizzato con Paolo Rumiz il podcast "Srebrenica - il genocidio dimenticato" per Chora Media, che ha raggiunto la prima posizione su Spotify Italia. «Srebrenica deriva da "srebro", argento - spiega - un ottimo conduttore che amalgama e tiene insieme. È questo il senso più profondo del mio lavoro: mettere in relazione persone lontane che pulsano sulla stessa frequenza d'onda».