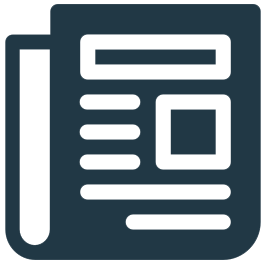"Amici miei", 50 anni di burle e malinconia. Grandissimo cinema
L'eredità di Germi con la mano di Monicelli. Il capolavoro della commedia all'italiana uscì in sala nell'agosto 1975

Giorgio Lambri
|13 giorni fa
Che cos’è il genio? Facile. “Fantasia, intuizione, decisione e velocità di esecuzione”. Quello di Pietro Germi si esprime nel 1974 con una sceneggiatura che sarà consegnata all’immortalità cinematografica, ma che l’immenso regista genovese non potrà ultimare, vinto nel dicembre di quello stesso anno da una malattia inesorabile. Quel progetto, intitolato “Amici miei”, vedrà la luce nelle principali sale cinematografiche d’Italia - con la guida di Mario Monicelli - esattamente mezzo secolo fa, il 15 agosto 1975, destinato a diventare un cult del cinema italiano, iconico tributo alla spensieratezza, che ci affranca dal fardello sociale di dovere per forza essere qualcuno.
A Piacenza la pellicola arriverà solo tre mesi dopo - il 28 novembre al cinema Iris - e il grande Giulio Cattivelli su “Libertà” ne coglierà subito il senso di “divertimento intelligente” capace di fondere “il dolce e l’amaro della vita, beffardo e crudele, scanzonato e melanconico, cinico e sentimentale”. Una conditio fondamentale per capirne il successo, che non è circoscrivibile alle zingarate, al parapia tapioca, alle burle goliardiche e a tutte quei neologismi diventati di uso comune (la supercazzola è da molti anni nello Zingarelli) ma affonda le sue radici nella malinconica disfatta esistenziale di quattro amici (più uno acquisito in corso d’opera) tanto diversi quanto accomunati dal senso ironico e amaro della risata, che è di fatto l’altra faccia della disperazione.
Su questa impalcatura “seria” è costruito con mirabile architettura cinematografica un film dai tempi comici perfetti, dal ritmo geniale, animato con umorismo crudele da personaggi unici, beffardi e inesorabili, cui danno anima attori di immensa levatura artistica: Philippe Noiret, Gastone Moschin, Duilio Del Prete, Adolfo Celi, ma su tutti un monumentale Ugo Tognazzi nei panni del conte Raffaello Mascetti. Che, per la cronaca, è ispirato a un personaggio realmente esistito - lo rivela lo sceneggiatore Piero De Bernardi - trattasi di un nobiluomo decaduto che aveva veramente fatto un viaggio di nozze di due anni con la moglie e l’orso al guinzaglio, divorandosi il patrimonio suo e della consorte. Allo stesso modo risponde a verità anche la storia della banda di gangster che prende di mira un odioso pensionato: fatto accaduto a Firenze e ascrivibile a un notaio, un barista e un magazziniere che tennero in scacco un vecchio particolarmente antipatico.
La “scuola toscana” della comicità (poi coltivata da Benigni, Nuti, Ceccherini, Panariello, Benvenuti e Pieraccioni, tanto per citare i più noti) nasce di fatto - sullo sfondo di una città annoiata, scolorita e nostalgica - con questi cinque strampalati amici, maschere della stessa tristezza: il giornalista disilluso che non sopporta la propria famiglia, il nobile decaduto disperatamente ottimista, l’architetto trombato da assessore “per una manciata di voti” e perennemente alla ricerca del vero amore, il barista indolente e “becco”; e - unico a salvarsi, forse - l’illustre clinico che risulta infatti quasi un intruso.
Mezzo secolo dopo “Amici miei” resta meravigliosamente attuale, con tutte le sue parabole e le sue regole e con quel dubbio che la voce narrante del Perozzi insinua sulle parole del figlio: “Io restai a chiedermi se l’imbecille ero io, che la vita la pigliavo tutta come un gioco, o se invece era lui che la pigliava come una condanna ai lavori forzati; o se lo eravamo tutti e due”.