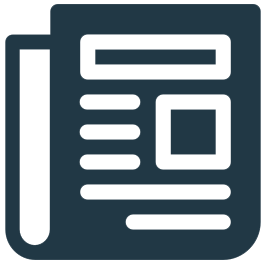Il peso della Fast Fashion: una piaga in quattro fasi
Dalla produzione all'acquisto, dall'utilizzo allo smaltimento
Leonardo Chiavarini
|1 mese fa

Ogni acquisto ha un peso. E non ci si riferisce soltanto al fardello che grava nella borsina della spesa, né all'economia domestica da tenere d'occhio nei portafogli personali, ma anche all'impatto che ciascuno di noi, da consumatore, può avere sul mondo. Ogni acquisto ha un peso perché, nel suo piccolo, può determinare logiche grandi, enormi, incisive.
La fast fashion è un esempio concreto e terribilmente attuale di tutto ciò. Con il termine anglosassone, si indica «quel settore della vendita al dettaglio di abbigliamento che realizza abiti di bassa qualità a prezzi molto ridotti, ma con la veloce disponibilità in negozio di nuove collezioni, continuamente riassortite» (Fonte: Legambiente Pc). Il fenomeno attrae i consumatori affascinati dall'idea di poter disporre di un guardaroba sempre nuovo, all'ultimo grido e acquistabile a prezzi contenuti. Cosa c'è di male? Potrebbe chiedersi qualcuno. Be', in un mondo dove purtroppo non esiste la bacchetta magica, il peso degli acquisti fast fashion ingombra, danneggia, inquina. E il problema, credeteci, non è riassumibile soltanto nelle montagne sterminate di scarti che affollano paesi e villaggi di lontani continenti, rese tristemente note da recenti documentari. No, il male della fast fashion non colpisce solo in quel modo, ma vive di 4 fasi. Un capo fast fashion, dunque di scarsa qualità, inquina dal giorno della sua nascita fino a quello della sua "morte”. La produzione, l'acquisto, l'utilizzo e lo smaltimento costituiscono 4 momenti ugualmente problematici.
La fast fashion è un esempio concreto e terribilmente attuale di tutto ciò. Con il termine anglosassone, si indica «quel settore della vendita al dettaglio di abbigliamento che realizza abiti di bassa qualità a prezzi molto ridotti, ma con la veloce disponibilità in negozio di nuove collezioni, continuamente riassortite» (Fonte: Legambiente Pc). Il fenomeno attrae i consumatori affascinati dall'idea di poter disporre di un guardaroba sempre nuovo, all'ultimo grido e acquistabile a prezzi contenuti. Cosa c'è di male? Potrebbe chiedersi qualcuno. Be', in un mondo dove purtroppo non esiste la bacchetta magica, il peso degli acquisti fast fashion ingombra, danneggia, inquina. E il problema, credeteci, non è riassumibile soltanto nelle montagne sterminate di scarti che affollano paesi e villaggi di lontani continenti, rese tristemente note da recenti documentari. No, il male della fast fashion non colpisce solo in quel modo, ma vive di 4 fasi. Un capo fast fashion, dunque di scarsa qualità, inquina dal giorno della sua nascita fino a quello della sua "morte”. La produzione, l'acquisto, l'utilizzo e lo smaltimento costituiscono 4 momenti ugualmente problematici.
LA PRODUZIONE
I due materiali principalmente impiegati nella fast fashion sono il cotone e il poliestere. Entrambi possono costituire una fonte di problemi in termini ambientali. Il poliestere proviene dal petrolio ed è il principale responsabile delle microplastiche presenti nei mari. Non è biodegradabile ed è poco traspirante, caratteristiche che lo rendono pericoloso sia per l'ambiente che per l'uomo. Il cotone comune (non biologico) è problematico per l'uso intensivo di pesticidi e insetticidi, che inquinano suolo e acque, impoveriscono la terra e danneggiano gli ecosistemi e la salute umana. Ambedue le fibre vengono poi trattate dall'industria. La colorazione dei tessuti, ad esempio, costituisce una delle attività più impattanti sull'ambiente: per produrre circa 400 miliardi di metri quadrati di tessuto colorato, vengono utilizzati quasi 9 trilioni di litri d'acqua, il che vuol dire che per un singolo capo, come ad esempio un vestito o un maglioncino, ne vengono utilizzati 2,500 litri. Allo spreco della risorsa idrica si unisce inoltre l'inquinamento delle sue rimanenze da parte delle tinture. Il Parlamento Europeo, citando dati dell'Agenzia europea dell'ambiente, riporta infatti che la produzione tessile è «responsabile di circa il 20% dell'inquinamento globale dell'acqua potabile».
I due materiali principalmente impiegati nella fast fashion sono il cotone e il poliestere. Entrambi possono costituire una fonte di problemi in termini ambientali. Il poliestere proviene dal petrolio ed è il principale responsabile delle microplastiche presenti nei mari. Non è biodegradabile ed è poco traspirante, caratteristiche che lo rendono pericoloso sia per l'ambiente che per l'uomo. Il cotone comune (non biologico) è problematico per l'uso intensivo di pesticidi e insetticidi, che inquinano suolo e acque, impoveriscono la terra e danneggiano gli ecosistemi e la salute umana. Ambedue le fibre vengono poi trattate dall'industria. La colorazione dei tessuti, ad esempio, costituisce una delle attività più impattanti sull'ambiente: per produrre circa 400 miliardi di metri quadrati di tessuto colorato, vengono utilizzati quasi 9 trilioni di litri d'acqua, il che vuol dire che per un singolo capo, come ad esempio un vestito o un maglioncino, ne vengono utilizzati 2,500 litri. Allo spreco della risorsa idrica si unisce inoltre l'inquinamento delle sue rimanenze da parte delle tinture. Il Parlamento Europeo, citando dati dell'Agenzia europea dell'ambiente, riporta infatti che la produzione tessile è «responsabile di circa il 20% dell'inquinamento globale dell'acqua potabile».
L'ACQUISTO
Una volta prodotto, un capo fast fashion non termina il suo ciclo inquinante. Ai packaging di plastica e agli imballaggi in polistirolo (minacce letali per la fauna marina), si associano le emissioni dei mezzi di trasporto che catapultano la merce da una parte all'altra del globo. Con l'avvento degli acquisti online, infatti, un numero sempre maggiore di capi è spedito per via aerea: si riducono i tempi di consegna, ma si moltiplicano a dismisura le emissioni nocive.
Una volta prodotto, un capo fast fashion non termina il suo ciclo inquinante. Ai packaging di plastica e agli imballaggi in polistirolo (minacce letali per la fauna marina), si associano le emissioni dei mezzi di trasporto che catapultano la merce da una parte all'altra del globo. Con l'avvento degli acquisti online, infatti, un numero sempre maggiore di capi è spedito per via aerea: si riducono i tempi di consegna, ma si moltiplicano a dismisura le emissioni nocive.
L'UTILIZZO
Lo abbiamo anticipato: i capi fast fashion, solitamente di scarsa qualità, possono avere anche un effetto nocivo sull'organismo di chi li utilizza. Composti organici volatili, alchilfenoli etossilati, formaldeide, ftalati, PFAS, metalli pesanti e tante altre sostanze dannose per la salute dell'uomo sono state rinvenute tra le fibre di questi indumenti: gli effetti negativi sono ingenti e in particolare riguardano la pelle e il sistema linfatico. L'utilizzo della moda "mordi e fuggi”, però, non è solo dannosa per l'uomo, ma anche per la natura. Si stima infatti che le microplastiche rilasciate dai tessuti sintetici durante i lavaggi domestici rappresentino il 35% dell'inquinamento degli oceani. A questi numeri occorre poi associarne altri: mezzo milione di microfibre vengono rilasciate in mare ogni anno in seguito ai lavaggi dei nostri vestiti, l'equivalente di 50 miliardi di bottiglie di plastica (fonte: Centre for sustainable fashion).
Lo abbiamo anticipato: i capi fast fashion, solitamente di scarsa qualità, possono avere anche un effetto nocivo sull'organismo di chi li utilizza. Composti organici volatili, alchilfenoli etossilati, formaldeide, ftalati, PFAS, metalli pesanti e tante altre sostanze dannose per la salute dell'uomo sono state rinvenute tra le fibre di questi indumenti: gli effetti negativi sono ingenti e in particolare riguardano la pelle e il sistema linfatico. L'utilizzo della moda "mordi e fuggi”, però, non è solo dannosa per l'uomo, ma anche per la natura. Si stima infatti che le microplastiche rilasciate dai tessuti sintetici durante i lavaggi domestici rappresentino il 35% dell'inquinamento degli oceani. A questi numeri occorre poi associarne altri: mezzo milione di microfibre vengono rilasciate in mare ogni anno in seguito ai lavaggi dei nostri vestiti, l'equivalente di 50 miliardi di bottiglie di plastica (fonte: Centre for sustainable fashion).
LO SMALTIMENTO
Infine, spesso il capo fast fashion, a causa della sua scarsa qualità, gode di vita breve. E i consumatori, in virtù della spesa contenuta e della continua e sovrabbondante disponibilità, non si fanno problemi a gettare il vecchio per comprare il nuovo. Tutto questo fa sì che ogni anno si accumulino, specie nelle aree più povere del mondo, tonnellate e tonnellate di rifiuto tessile. Il deserto dell'Atacama (Cile) è forse il ritratto più sconvolgente del lato oscuro della fast fashion: montagne di scarti accatastati formano un tetro monumento che raffigura il vero prezzo del consumismo sfrenato.
Infine, spesso il capo fast fashion, a causa della sua scarsa qualità, gode di vita breve. E i consumatori, in virtù della spesa contenuta e della continua e sovrabbondante disponibilità, non si fanno problemi a gettare il vecchio per comprare il nuovo. Tutto questo fa sì che ogni anno si accumulino, specie nelle aree più povere del mondo, tonnellate e tonnellate di rifiuto tessile. Il deserto dell'Atacama (Cile) è forse il ritratto più sconvolgente del lato oscuro della fast fashion: montagne di scarti accatastati formano un tetro monumento che raffigura il vero prezzo del consumismo sfrenato.

UN ANTIDOTO LENTO ALLA MODA CHE CORRE
Come si può contrastare la fast fashion? Certo, la politica dovrebbe meditare soluzioni di ampio respiro per salvaguardare al contempo l'ambiente e i negozi di prossimità; eppure, anche ciascuno di noi, nel suo piccolo, ha il potere di fare qualcosa di davvero importante. Come? Be', siamo tutti consumatori e, acquistando in maniera intelligente, possiamo contribuire a dare un indirizzo al mercato. Alla Fast fashion (moda veloce), sarebbe il caso di preferire la cosiddetta Slow fashion (moda lenta). Con quest'altro termine anglosassone si cerca di riassumere una moda che favorisca prodotti resistenti e duraturi, rivaluti la manodopera e valorizzi materiali di qualità ed ecosostenibili. Le strategie slow fashion sono tante. È possibile dare nuova vita a ciò che si ha già nell'armadio, acquistare con più attenzione, magari preferendo i capi dotati di etichette che certifichino che la lavorazione sia davvero avvenuta secondo principi etici e sostenibili; oppure si possono scegliere prodotti di alta qualità, magari più costosi ma più duraturi. Infine, un'alternativa in crescita e sicuramente "slow” è quella che riguarda il mondo del vintage e del second hand. Una piccola voce fuori dal coro, che, però, sta riuscendo a farsi sentire. In ogni modo, la mossa più importante avviene in fase di smaltimento. I capi di abbigliamento vanno preferibilmente conservati e, se proprio occorre liberarsene, è giusto farlo in maniera consapevole, evitando di optare per il conferimento nel rifiuto indifferenziato o, peggio, per l'abbandono.
Come si può contrastare la fast fashion? Certo, la politica dovrebbe meditare soluzioni di ampio respiro per salvaguardare al contempo l'ambiente e i negozi di prossimità; eppure, anche ciascuno di noi, nel suo piccolo, ha il potere di fare qualcosa di davvero importante. Come? Be', siamo tutti consumatori e, acquistando in maniera intelligente, possiamo contribuire a dare un indirizzo al mercato. Alla Fast fashion (moda veloce), sarebbe il caso di preferire la cosiddetta Slow fashion (moda lenta). Con quest'altro termine anglosassone si cerca di riassumere una moda che favorisca prodotti resistenti e duraturi, rivaluti la manodopera e valorizzi materiali di qualità ed ecosostenibili. Le strategie slow fashion sono tante. È possibile dare nuova vita a ciò che si ha già nell'armadio, acquistare con più attenzione, magari preferendo i capi dotati di etichette che certifichino che la lavorazione sia davvero avvenuta secondo principi etici e sostenibili; oppure si possono scegliere prodotti di alta qualità, magari più costosi ma più duraturi. Infine, un'alternativa in crescita e sicuramente "slow” è quella che riguarda il mondo del vintage e del second hand. Una piccola voce fuori dal coro, che, però, sta riuscendo a farsi sentire. In ogni modo, la mossa più importante avviene in fase di smaltimento. I capi di abbigliamento vanno preferibilmente conservati e, se proprio occorre liberarsene, è giusto farlo in maniera consapevole, evitando di optare per il conferimento nel rifiuto indifferenziato o, peggio, per l'abbandono.
IL COSTO SOCIALE E UMANO: LAVORATORI PAGATI 1 DOLLARO L'ORA
La piaga della Fast Fashion non è solo ambientale, ma anche umana. La produzione di questo genere di capi d'abbigliamento è spesso affidata dalle note Catene ad altre aziende localizzate in Paesi in via di sviluppo, nel Sudest asiatico, nel Nordafrica e in Sudamerica. Qui, in fabbriche in cui vige la logica assoluta di abbattimento dei costi, gli operai sono costretti a ritmi estenuanti, vengono sottopagati, sfruttati e spesso si trovano a lavorare in ambienti nocivi per la salute, privi di qualsiasi tutela. Il documentario "Fashion victims” è tra i tanti a raccontare le storture sociali e umane di questa industria: in Bangladesh, ad esempio, la manodopera di alcuni operai arriva a essere pagata meno di 1 dollaro al giorno. Proprio i luoghi del mondo che ospitano la manodopera sfruttata sono poi gli stessi che si ritrovano a dover gestire le tonnellate di rifiuti tessili di ritorno dalle zone più ricche, nel segno di un circolo vizioso molteplice e beffardo. La responsabilità di tutto questo è in capo alle aziende, ma ricade in parte sui consumatori che, nel nome di un guardaroba variegato e sempre nuovo (oltre che acquistato a poco prezzo), alimentano un'industria iniqua e dannosa.
La piaga della Fast Fashion non è solo ambientale, ma anche umana. La produzione di questo genere di capi d'abbigliamento è spesso affidata dalle note Catene ad altre aziende localizzate in Paesi in via di sviluppo, nel Sudest asiatico, nel Nordafrica e in Sudamerica. Qui, in fabbriche in cui vige la logica assoluta di abbattimento dei costi, gli operai sono costretti a ritmi estenuanti, vengono sottopagati, sfruttati e spesso si trovano a lavorare in ambienti nocivi per la salute, privi di qualsiasi tutela. Il documentario "Fashion victims” è tra i tanti a raccontare le storture sociali e umane di questa industria: in Bangladesh, ad esempio, la manodopera di alcuni operai arriva a essere pagata meno di 1 dollaro al giorno. Proprio i luoghi del mondo che ospitano la manodopera sfruttata sono poi gli stessi che si ritrovano a dover gestire le tonnellate di rifiuti tessili di ritorno dalle zone più ricche, nel segno di un circolo vizioso molteplice e beffardo. La responsabilità di tutto questo è in capo alle aziende, ma ricade in parte sui consumatori che, nel nome di un guardaroba variegato e sempre nuovo (oltre che acquistato a poco prezzo), alimentano un'industria iniqua e dannosa.