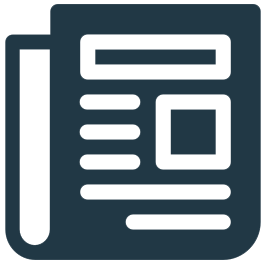Mangia, scappa, vinci: il videogioco "Pac-Man" compie 45 anni
Con oltre 90 milioni di unità vendute e 15 miliardi di dollari di incasso, si conferma un'icona intramontabile del mondo videoludico
Fabrizia Malgieri
|3 mesi fa
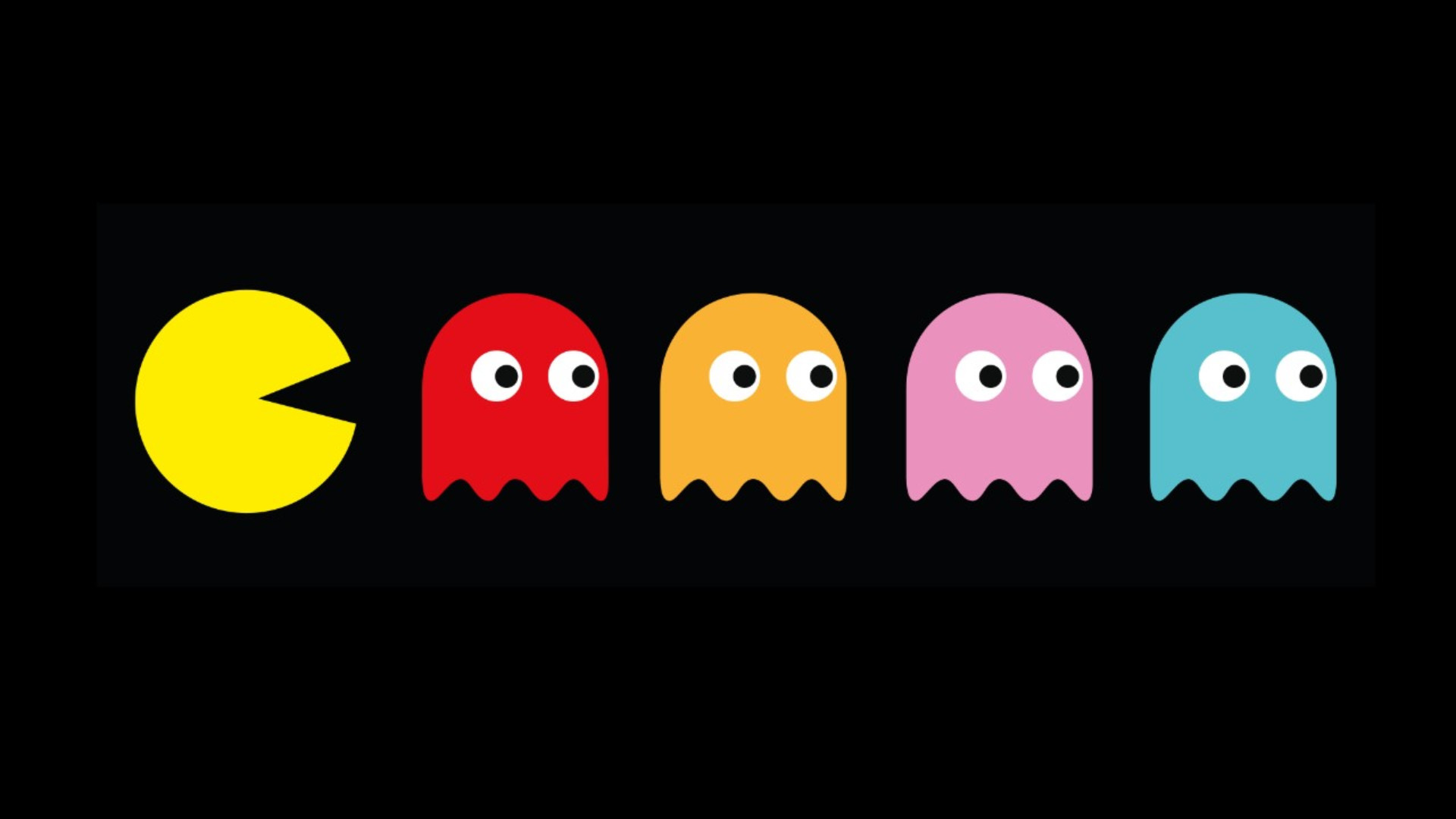
"Pac-Man" compie 45 anni- © Libertà/Fabrizia Malgieri
La sua intro con musica elettronica in 8bit è stata un’importante fonte d’ispirazione per la nascita del movimento hip-hop degli anni Ottanta. È stato concepito dal suo creatore, il game designer Toru Iwatani, per avvicinare il pubblico femminile al mondo dei videogiochi. È una semplice pallina di colore giallo, che naviga in un buio labirinto psichedelico inseguita da un gruppo di fantasmi colorati, divorando piccole pastiglie. “Pac-Man” – il popolare videogioco arcade di Namco – celebra oggi, 10 ottobre, i suoi primi 45 anni, confermandosi una delle icone più longeve della storia dei videogiochi. Installato per la prima volta nel giugno 1980 in un piccolo cinema di Shibuya, a Tokyo, “Pac-Man” ha raggiunto la popolarità solo nei mesi successivi, quando in autunno arrivò per la prima volta negli Stati Uniti grazie all’azienda di distribuzione Midway, molto popolare negli anni Ottanta per aver importato molti videogiochi giapponesi in formato cabinato, contribuendone al successo mondiale. Fu la stessa Midway a optare per il nome “Pac-Man”: infatti, in origine il titolo era “Puck-Man”, ma dal momento che la parola “Puck” poteva essere facilmente vandalizzata e trasformata in qualcosa di volgare, la compagnia decise di modificare la prima parte.

Ma come nasce il fenomeno di “Pac-Man”? Attorno al gioco si sono rincorse negli anni diverse storie, alcune delle quali confermate dal suo stesso creatore, Toru Iwatani: per anni, lo sviluppatore giapponese ha raccontato di aver dato forma al suo “eroe” rotondo osservando un piatto di pizza, a cui mancava una fetta, durante una cena con amici; nel tempo, Iwatani ha aggiunto ulteriori dettagli, sostenendo che in realtà si sarebbe ispirato anche all’ideogramma giapponese per la parola “bocca” (kuchi).Di sicuro, il cibo è il tema attorno cui ruota lo stesso videogioco: il suo gameplay – nelle sue regole e meccaniche piuttosto semplici, quanto meno ad una prima occhiata – vede, infatti, Pac-Man muoversi lungo numerosi livelli con forme labirintiche, divorando piccole pastiglie (che simbolicamente rappresentano dei biscotti), nel tentativo di sfuggire a quattro fantasmi colorati, con occhi graziosi da cerbiatto. Tuttavia, nel momento in cui Pac-Man riesce a entrare in possesso di uno dei power-up sparsi attorno al livello, il gioco ribalta la situazione: la pallina gialla diventa invincibile e inizia a inseguire i fantasmi, tentando di divorarli con le proprie fauci per un breve lasso di tempo. Il livello viene completato nel momento in cui Pac-Man ha mangiato tutti i puntini (che gli permettono di accumulare un punteggio), alternandoli anche ai diversi frutti o dolcetti bonus che compaiono in modo randomico all’interno del “quadro” di gioco.

Nella sua semplicità, “Pac-Man” si fa precursore di molte innovazioni videoludiche, quanto meno per l’epoca: in primo luogo, è tra i primi videogiochi – ancor prima di “Donkey Kong”, che arriverà solo l’anno successivo e che vede una delle prime apparizioni di Super Mario (all’epoca noto come “Jumpman”) – ad introdurre la meccanica dei power-up (o potenziamenti), che conferiscono al personaggio una sorta di invincibilità o abilità uniche per un breve lasso di tempo. La leggenda narra che Iwatani si sia ispirato al concetto dei power-up guardando i cartoni animati di “Braccio di Ferro”: il celebre personaggio, ideato da Elzie Crisler Segar nel 1929, acquisisce una forza straordinaria, anche se per un periodo limitato, assumendo i famosi spinaci. Allo stesso modo, anche Pac-Man, mangiando i biscotti più grandi disseminati per il livello, ottiene temporaneamente il potere di contrastare i fantasmi.
L’altra grande innovazione introdotta da “Pac-Man” è la presenza di “proto-cutscene”: nel videogioco contemporaneo, a partire dagli anni Novanta in poi, per “cutscene” si intendono quelle scene di intermezzo, non giocabili, che raccontano la trama del titolo tra una sequenza giocata e l’altra. Nel gioco di Iwatani non vengono chiamate “cutscene” bensì “coffee-break”: si tratta di piccoli intermezzi, di carattere comico, che ricordano le scenette tipiche delle slapstick-comedy, che vengono posizionate tra un livello e l’altro, in cui vediamo i fantasmi rincorrere Pac-Man o viceversa. In realtà, in questo caso non raccontano una storia come nei videogiochi più moderni, ma funzionano da raccordo tra un livello e l’altro. A proposito di questa dinamica di ribaltamento dei ruoli all’interno del gioco, in gergo aziendale con la cosiddetta “difesa Pac-Man” si intende una strategia per cui un’azienda, magari presa di mira da un’acquisizione ostile, tenta di ribaltare la situazione e prova ad acquistare l’acquirente.
L’altra grande innovazione introdotta da “Pac-Man” è la presenza di “proto-cutscene”: nel videogioco contemporaneo, a partire dagli anni Novanta in poi, per “cutscene” si intendono quelle scene di intermezzo, non giocabili, che raccontano la trama del titolo tra una sequenza giocata e l’altra. Nel gioco di Iwatani non vengono chiamate “cutscene” bensì “coffee-break”: si tratta di piccoli intermezzi, di carattere comico, che ricordano le scenette tipiche delle slapstick-comedy, che vengono posizionate tra un livello e l’altro, in cui vediamo i fantasmi rincorrere Pac-Man o viceversa. In realtà, in questo caso non raccontano una storia come nei videogiochi più moderni, ma funzionano da raccordo tra un livello e l’altro. A proposito di questa dinamica di ribaltamento dei ruoli all’interno del gioco, in gergo aziendale con la cosiddetta “difesa Pac-Man” si intende una strategia per cui un’azienda, magari presa di mira da un’acquisizione ostile, tenta di ribaltare la situazione e prova ad acquistare l’acquirente.

Non tutti sanno che “Pac-Man”, in realtà, è un gioco per cui non è prevista una vera e propria conclusione: l’ultimo livello che è possibile completare è il 256, dopodiché il lato destro del labirinto inizia a collassare, dando vita ad una sorta di caos fatto di numeri e lettere, che rende di fatto impossibile andare oltre. Pac-Man, ovviamente, “muore”, ma non appare una vera e propria schermata di “Game Over”: questo perché lo stesso Iwatani, quando con il suo team di lavoro ha sviluppato il gioco, riteneva impossibile che qualcuno sarebbe mai riuscito a spingersi così in avanti nell’esperienza di gioco – e questo anche perché non era sicuro se e quando il software che muove il gioco avrebbe esaurito la sua memoria. Chi è riuscito a raggiungere il livello 256, ottenendo un “perfect score” di 3.333.360 punti (il punteggio massimo tra pallini, bonus e fantasmi) è lo statunitense David Race, il quale ha completato il gioco in appena 3 ore, 28 minuti e 49 secondi il 22 giugno 2013. Da allora, nessuno è riuscito ad eguagliare il suo risultato, restando, di fatto, l’attuale campione in carica di “Pac-Man” al mondo.
Se ci fossero ancora dubbi sull’importanza di “Pac-Man” nella cultura popolare, ci sarebbe un’ultima curiosità: nel 2012 l’opera videoludica è stata inserita tra i 14 videogiochi nella collezione del MoMA di New York, all’interno della galleria di architettura e design. Un riconoscimento artistico molto importante, che conferma, ancora una volta, quanto i videogiochi siano oggi un medium imprescindibile per raccontare il nostro vissuto degli ultimi 40 o 50 anni, entrando a far parte – e a pieno diritto – della nostra storia culturale, esattamente come tante altre forme d’arte e di intrattenimento.
Se ci fossero ancora dubbi sull’importanza di “Pac-Man” nella cultura popolare, ci sarebbe un’ultima curiosità: nel 2012 l’opera videoludica è stata inserita tra i 14 videogiochi nella collezione del MoMA di New York, all’interno della galleria di architettura e design. Un riconoscimento artistico molto importante, che conferma, ancora una volta, quanto i videogiochi siano oggi un medium imprescindibile per raccontare il nostro vissuto degli ultimi 40 o 50 anni, entrando a far parte – e a pieno diritto – della nostra storia culturale, esattamente come tante altre forme d’arte e di intrattenimento.