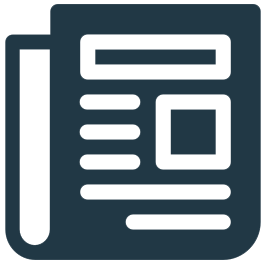Green Future, la scienza brilla nella sua notte
Quasi in mille per celebrare la ricerca
Leonardo Chiavarini
|3 mesi fa

La Settimana della scienza è stata celebrata anche a Piacenza
La scienza attrae e convince. Con oltre 600 studenti nelle ore diurne e più di 150 visitatori nelle ore serali, a Piacenza, la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici 2025 ha riscosso un grande interesse. Il sabato, negli spazi del Laboratorio Aperto-Ex Chiesa del Carmine, è stato all'insegna della divulgazione e ha suggellato la Settimana della scienza, appena conclusa. L'iniziativa, svoltasi al Laboratorio Aperto, è stata l'esito di una collaborazione tra il Comune di Piacenza e Frascati Scienza, nell'ambito del progetto europeo Leaf, finanziato dal programma Horizon 2020. A Piacenza, inoltre, è stato fondamentale il coinvolgimento delle università e dei centri di ricerca diffusi sul territorio, che, per un giorno, si sono avvicinati più che mai alla cittadinanza, portando nella "piazza” dell'Ex Carmine un po' del loro sapere.
Prima del gran finale sulle note del Conservatorio Nicolini, la Notte Europea dei ricercatori e delle ricercatrici ha riservato decine di laboratori e iniziative e, soprattutto, un talk. Intorno alle 19.45, infatti, una folta platea si è radunata all'Ex Carmine, curiosa di seguire "Perché no?”, l'evento curato da Piacenza Talenti (sportello del Comune) per approfondire il ruolo del pensiero laterale nella ricerca scientifica. Cosa si intende per "pensiero laterale”? Generalmente, l'espressione indica la capacità di pensare fuori dagli schemi, la tendenza a risolvere i problemi da prospettive diverse. Ma, sabato sera, a spiegare 3 differenti accezioni di pensiero laterale sono stati, a turno, 3 ospiti d'eccezione: Silvia Bencivelli, Andrea Bariselli e Alberto Grandi, moderati da Paolo Gentilotti di "Libertà” e successivamente in dialogo con il professor Edoardo Puglisi dell'Università Cattolica.
Prima del gran finale sulle note del Conservatorio Nicolini, la Notte Europea dei ricercatori e delle ricercatrici ha riservato decine di laboratori e iniziative e, soprattutto, un talk. Intorno alle 19.45, infatti, una folta platea si è radunata all'Ex Carmine, curiosa di seguire "Perché no?”, l'evento curato da Piacenza Talenti (sportello del Comune) per approfondire il ruolo del pensiero laterale nella ricerca scientifica. Cosa si intende per "pensiero laterale”? Generalmente, l'espressione indica la capacità di pensare fuori dagli schemi, la tendenza a risolvere i problemi da prospettive diverse. Ma, sabato sera, a spiegare 3 differenti accezioni di pensiero laterale sono stati, a turno, 3 ospiti d'eccezione: Silvia Bencivelli, Andrea Bariselli e Alberto Grandi, moderati da Paolo Gentilotti di "Libertà” e successivamente in dialogo con il professor Edoardo Puglisi dell'Università Cattolica.

La prima a prendere la parola è stata proprio Silvia Bencivelli, giornalista scientifica, scrittrice, e conduttrice radio e tv. Il suo discorso ha ricostruito alcune tappe importanti della storia scientifica, ma si è più che altro focalizzato su alcune trappole della mente umana, su alcune fallacie del ragionamento. Insomma, per spiegare cos'è il pensiero laterale, Bencivelli è partita con il definire i suoi molti contrari, ovvero i vizi in cui la nostra mente ricade di continuo, vuoi per esiti evolutivi, vuoi per sua stessa conformazione. E così dal misoneismo (avversione per le innovazioni), si è passati all'animismo (credenza per cui ogni cosa sarebbe dotata di anima); dall'Effetto Dunning-Kruger (la tendenza di individui poco esperti in un campo a sovrastimare a torto la propria preparazione) si è arrivati all'ultracrepidarismo (esprimere opinioni al di fuori della propria competenza). «Il pensiero laterale - ha spiegato Bencivelli - è il contrario di queste fallacie, sfugge agli stereotipi, cambia strada rispetto ai percorsi più tradizionali e porta a "fiutare” aspetti che altrimenti non coglieremmo».
Andrea Bariselli è invece uno psicologo e neuroscienziato, nonché autore e divulgatore. Il suo talk si è focalizzato sul cervello umano e, in particolare, sulla sua neuroplasticità, ovvero la capacità del nostro organo primario di cambiare a seconda degli stimoli esterni a cui è sottoposto. Proprietà che a volte può creare vantaggi, altre volte svantaggi alla specie umana. Il discorso di Bariselli ha poi toccato un tema delicato e attuale: il crescente distacco tra uomo e natura, un rapporto naturale, oggi inficiato dall'evoluzione. L'invito dello studioso è stato quello di cambiare la propria prospettiva sulle cose del mondo, ridare a esse un senso e ritrovare il coraggio di osservare e di stupirsi. «La meraviglia e l'emotività – spiega Bariselli – sono risorse che possono aiutarci a uscire dagli schemi di pensiero dominanti e trovare nuove prospettive». Infine, il lato più provocatorio e tagliente del pensiero laterale è arrivato dal discorso di Alberto Grandi, professore di Economia e management, nonché autore del best seller "Denominazione di Origine inventata”, con cui ha portato avanti teorie che confutano alcuni capisaldi della tradizione culinaria italiana, fino a considerare quest'ultima un frutto del marketing di secondo Novecento. «Una storia poco conosciuta – dice – che merita di essere raccontata».
Andrea Bariselli è invece uno psicologo e neuroscienziato, nonché autore e divulgatore. Il suo talk si è focalizzato sul cervello umano e, in particolare, sulla sua neuroplasticità, ovvero la capacità del nostro organo primario di cambiare a seconda degli stimoli esterni a cui è sottoposto. Proprietà che a volte può creare vantaggi, altre volte svantaggi alla specie umana. Il discorso di Bariselli ha poi toccato un tema delicato e attuale: il crescente distacco tra uomo e natura, un rapporto naturale, oggi inficiato dall'evoluzione. L'invito dello studioso è stato quello di cambiare la propria prospettiva sulle cose del mondo, ridare a esse un senso e ritrovare il coraggio di osservare e di stupirsi. «La meraviglia e l'emotività – spiega Bariselli – sono risorse che possono aiutarci a uscire dagli schemi di pensiero dominanti e trovare nuove prospettive». Infine, il lato più provocatorio e tagliente del pensiero laterale è arrivato dal discorso di Alberto Grandi, professore di Economia e management, nonché autore del best seller "Denominazione di Origine inventata”, con cui ha portato avanti teorie che confutano alcuni capisaldi della tradizione culinaria italiana, fino a considerare quest'ultima un frutto del marketing di secondo Novecento. «Una storia poco conosciuta – dice – che merita di essere raccontata».